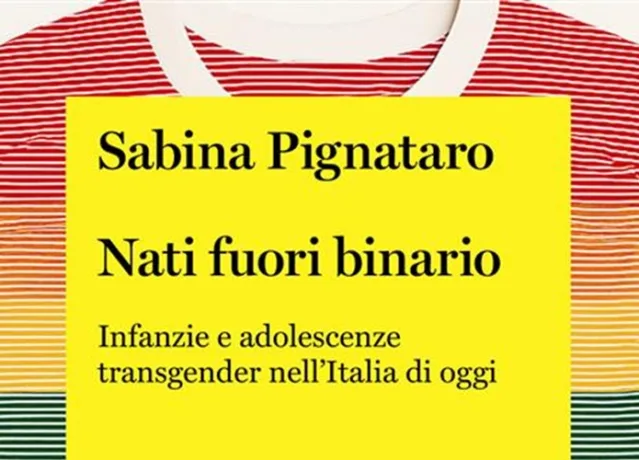
CHIARA, 9 ANNI: «MI CHIAMAVO LORENZO, MA IL MIO NOME ERA COME UN PAIO DI SCARPE STRETTE»
Quella di Chiara è una delle voci in “Nati fuori binario”. Tra le pagine di Sabina Pignataro un viaggio per consultori, scuole, spazi associativi, ospedali tra i ragazzi che stanno tracciando nuovi percorsi di identità. «Più raccoglievo storie, più mi rendevo conto di quanto poco si sa di questi vissuti. E di quanto questo alimenti paura, ostilità, disinformazione. In un’Italia in cui l’identità di genere è diventata visibile, ma spesso solo per essere strumentalizzata»
20 Novembre 2025
5 MINUTI di lettura
ASCOLTA L'ARTICOLO
«Mi chiamavo Lorenzo. Ma io non mi sono mai sentita un maschio. Non era una cosa che pensavo. Era una cosa che sentivo. Come quando ti metti un paio di scarpe strette: all’inizio provi a camminarci, ma poi fa sempre più male. Così era il mio nome. Così era essere chiamata “lui”. Una dottoressa mi ha chiesto: “Come ti senti quando ti chiamano così?” E io ho risposto piano, ma senza tremare: “Mi sento sbagliata”. Lei ha annuito. E non ha cercato di aggiustarmi», racconta Chiara, bambina trans di 9 anni. La sua è una delle voci a cui si aggiungono quelle di altri ragazzi, di padri e madri, psicologi e psicoterapeuti, di un’endocrinologa e una scrittrice, nel volume della giornalista e antropologa Sabina Pignataro intitolato Nati fuori binario. Infanzie e adolescenze transgender nell’Italia di oggi, edito da Il Margine/Erickson. «Nel 2019 è nato il mio interesse per i bambini e gli adolescenti che vivono un’incongruenza di genere e si definiscono transgender», spiega l’autrice, che sei anni fa preparava un’inchiesta su questo tema delicato.
«Stare dentro ai binari rosa e azzurri può diventare insopportabile, quando quei binari non sono scelti»
«In questi anni mi sono addentrata in consultori, scuole, spazi associativi, reparti ospedalieri: luoghi in cui l’identità non è un punto di partenza, ma un processo. Un cammino fatto di attese, tensioni, passi incerti e slanci coraggiosi. Ho incontrato bambini e ragazzi, famiglie, genitori, specialisti che camminavano fianco a fianco, tra silenzi, domande e alfabeti ancora da inventare», racconta Pignataro. E precisa: «Più raccoglievo storie, più mi rendevo conto di quanto poco si sa davvero di questi vissuti. E di quanto questa mancanza di conoscenza alimenti paura, ostilità, disinformazione. Ho scelto di concentrarmi sui minori, raccontando i vissuti dell’Italia tra il 2024 e il 2025. Un tempo in cui l’identità di genere è diventata visibile, ma spesso solo per essere strumentalizzata: nei talk show, nei titoli sensazionalistici di alcuni giornali, nelle leggi mai scritte». I percorsi di questi giovani che stanno tracciando nuovi percorsi di identità «non seguono mai una linea retta: c’è chi inizia presto, chi più tardi; chi avanza, chi si ferma, chi torna indietro solo per trovare un sentiero nuovo». Persone che, «in modi diversi, cercano ascolto, riconoscimento, spazio per respirare. Perché stare dentro ai binari rosa e azzurri può diventare insopportabile, quando quei binari non sono scelti, ma imposti. Quando non raccontano chi sei, ma solo chi gli altri si aspettano che tu sia».
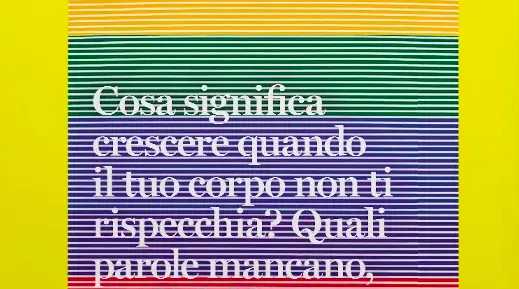
Al San Camillo Forlanini e al Policlinico Umberto I a Roma due centri dedicati
Le attuali linee guida della World Professional Association for Transgender Health, pubblicate nel 2022 stimano che «a livello globale, tra gli adulti la percentuale di persone transgender vari dallo 0,3% allo 0,5%; tra i minori, invece, la stima sale, si va dall’1,2% al 2,7%. Tuttavia, la stessa Wpath invita alla cautela: le stime disponibili sono ancora limitate, e variano a seconda di come vengono raccolti i dati, del contesto culturale, delle parole usate nei sondaggi». Tuttavia «non tutti coloro che si identificano come transgender nell’infanzia mantengono questa identità in età adulta. Alcuni, col tempo, si riconoscono nel genere assegnato alla nascita. Ma non esistono strumenti affidabili per prevedere come evolverà il percorso di una persona. Ogni storia è diversa. E ogni tentativo di semplificazione rischia di trasformarsi in un fraintendimento — o in una forma di violenza simbolica». In Italia l’Osservatorio nazionale sull’identità di Genere ha attivato una rete di 9 centri specializzati per minorenni con vissuti di varianza di genere, 2 dei quali nel Lazio (a Roma): l’Area minori del Saifip (Servizio adeguamento identità fisica all’identità psichica) – di cui è responsabile la psicologa e psicoterapeuta Maddalena Mosconi – è attiva presso l’Ospedale San Camillo-Forlanini, mentre al Policlinico Umberto I è presente l’ambulatorio di Endocrinologia e Andrologia. «Propongono percorsi multidisciplinari che coinvolgono psicologi, endocrinologi, psichiatri, assistenti sociali», spiega Pignataro. «Spesso — ma non sempre — non è la consapevolezza di sé a far soffrire. È lo sguardo degli altri. L’obbligo a giustificarsi. Il dover tacere per non perdere l’amore o l’appartenenza. È lì che la disforia, quando c’è, si intreccia con un senso di esclusione, di inadeguatezza, di solitudine», spiega la dottoressa Mosconi, precisando: « Ci sono bambini che, quando si sentono accolti, sbocciano. Ridono, giocano, fanno amicizia. Hanno risorse, parole, desideri. Non sono soggetti fragili da proteggere a ogni costo».
Il gruppo GenerAzioneD
Ma sono le testimonianze dirette a consentire di entrare nel cuore del fenomeno. Francesca, madre di un ragazzo transgender, scrive: «Lo vedo muoversi, parlare, scegliere vestiti diversi, stare zitto su cose che prima raccontava. Come se qualcosa fosse cambiato e io fossi l’ultima a capirlo. Ha dodici anni. Ultimamente si arrabbia spesso. O si chiude in camera e non esce. Ha smesso di andare in piscina, e io non so più se insistere o lasciar perdere. Dice che odia il suo nome. Che non vuole più indossare certe magliette. Che non si sente “a posto”. Ma poi si blocca. Si confonde. Si rimangia tutto. Io non so se è solo un momento. Una fase. O se è qualcosa di più profondo. (…) Vorrei solo che stesse bene. Ma non so cosa voglia dire, adesso, per lui, stare bene. E questo, più di tutto, è ciò che mi spezza». E Alessandra, madre di Matteo, racconta: «Lucia aveva sette anni quando, davanti a tutta la classe, ha detto: “Il mio sogno è essere maschio. E voglio chiamarmi Matteo”. Era l’attività dei sogni nel cassetto: ogni bambino diceva cosa desiderava diventare. Ma quella frase, detta con una semplicità disarmante, ha spezzato il gioco. Perché per lui non era un gioco. Era una verità che aspettava solo di essere detta. (…) Oggi Matteo sta bene. È un ragazzo sereno, consapevole. Si sente finalmente visto, riconosciuto. Ma sa anche che non ovunque troverà comprensione. (…) Io non so cosa lo aspetta. Ma una cosa l’ho imparata: ascoltare cambia tutto. Non siamo noi a decidere chi sono i nostri figli. Il nostro compito è camminare al loro fianco, mentre imparano a diventarlo».
Molti genitori «da figure incerte o disorientate diventano presenze attive, capaci di prendere parola nello spazio pubblico per affermare i diritti dei propri figli. Fondano gruppi, dialogano con le istituzioni, sollecitano riforme, scrivono lettere, partecipano a colloqui, promuovono formazione. È un attivismo quotidiano, tenace, che nasce dall’amore ma si concretizza in pratiche politiche e sociali», riferisce la giornalista. E cita il gruppo GenerAzioneD, nato due anni fa e formato da madri e padri che hanno scelto di mantenere l’anonimato: si propone di «informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle complessità legate alla disforia o incongruenza di genere nei bambini, adolescenti e giovani adulti».
—————————————–
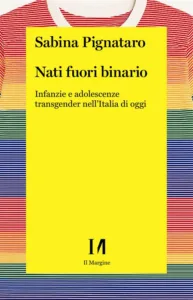 Sabina Pignataro
Sabina Pignataro
Nati fuori binario
Infanzie e adolescenze transgender nell’Italia di oggi
Il Margine/Erickson, 2025
pp.152, € 10,00








