
VIOLENZA SULLE DONNE, PREVENZIONE E EDUCAZIONE SESSUO-AFFETTIVA A SCUOLA. PIÙ CHE MAI NECESSARIA
Con Celeste Costantino sui passi compiuti nel contrasto alla violenza sulle donne. E su quello che manca, a partire dalla prevenzione primaria e l'educazione sessuo-affettiva a scuola, grande “buco nero” dell’educazione. «C’è un clima pesante, rimaniamo gli unici in Europa a non avere l’educazione sessuo-affettiva nell’ordinamento scolastico e ai pochi progetti che si riescono a portare avanti si mettono i bastoni fra le ruote, negandone l’efficacia»
25 Novembre 2025
8 MINUTI di lettura
ASCOLTA L'ARTICOLO
«Oggi ci ritroviamo all’interno di un dibattito che addirittura ci mette nella condizione di difendere qualcosa che non c’è», dice riferendosi all’educazione sessuo-affettiva Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila e curatrice insieme a Giulia Minoli e Monica Pasquino del libro Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva è una questione politica (Tlon).
Costantino, lei fa attivismo da più di vent’anni. A che punto siamo in questa Giornata contro la violenza sulle donne 2025?
«Se mi guardo indietro, non posso assolutamente dire che non è cambiato niente. Ricordo con quanta solitudine si affrontavano certi progetti, certe discussioni. Ora su tante questioni siamo in un altro mondo. Dobbiamo guardare con favore al fatto che sia stata votata all’unanimità la legge sul consenso, quello è un passaggio cruciale, che può cambiare l’andamento di tanti processi, evitare la vittimizzazione secondaria, riuscire ad avere uno sguardo diverso sugli stupri, anche da un punto di vista culturale. Di cose in questi ultimi anni, per il contrasto alla violenza sulle donne, ne sono state fatte. Quindi guardo a questo 25 novembre con un bilancio che dimostra un’attenzione. Dobbiamo essere brave e bravi noi nel cercare di dirottare l’impegno che c’è sull’argomento rafforzando la parte di prevenzione. Il problema è tutto lì. Dal punto di vista securitario, dal punto di vista delle norme, sul fronte del post, della violenza avvenuta, l’Italia ha messo in campo norme che stanno funzionando. E vedo un’attenzione in più anche da parte degli operatori. I centri antiviolenza rimangono i luoghi per eccellenza a cui le donne si devono rivolgere. Però, per esempio, abbiamo chiuso da poco un protocollo con Polizia di Stato per la formazione e anche quello è un passaggio fondamentale. Prima le donne che denunciavano potevano trovarsi davanti figure che, nella migliore delle ipotesi, non erano nemmeno in grado di capire quello che stavano dicendo, o venivano invitate a ritornare a casa dal proprio maltrattante. Gli interlocutori non erano in grado di interpretare la violenza, era tutto normalizzato. Alcuni casi del genere ci sono ancora, accanto, però, ad un interesse a colmare questo vuoto, a cercare il più possibile di efficientare il meccanismo per la fuoriuscita dalla violenza, con formazione ai magistrati, alle forze dell’ordine. Così come sarebbe necessaria una grandissima formazione sugli assistenti sociali, riguardo il grande problema delle donne con figli che si ritrovano a viversi separazioni devastanti. Il fatto che si sia accesa una luce, un riflettore, che sta continuando nel tempo, ci mette nelle condizioni di poter fare rivendicazioni in più. A mancare è la prevenzione primaria e il tema dell’educazione sessuo-affettiva è il grande “buco nero” dell’educazione, a tutto il resto ci stiamo man mano arrivando. Sulla parte scolastica, quella che interviene prima che la violenza venga, che deve servire a decostruire gli stereotipi, a fare lavoro culturale, su quello ancora siamo molto indietro. E questo Governo ci sta facendo fare ulteriori passi indietro».

In questo momento quanto è necessario un libro come il vostro?
«Quando abbiamo pensato questo libro non immaginavamo che sarebbe uscito dentro questo clima politico, dentro questa discussione infuocata. Doveva avere e sta avendo questa funzione: è uno strumento di dibattito e di discussione per cercare di promuovere l’educazione sesso-affettiva nelle scuole. Oggi ci ritroviamo in un dibattito che addirittura ci deve mettere in una condizione di difendere qualcosa che non c’è. Nel libro c’è il racconto delle esperienze nell’ultimo decennio a scuola, in assenza di una legge che istituzionalizzasse l’educazione sessuo-affettiva. Spiega, per esempio, l’azione che hanno avuto i centri antiviolenza, il movimento Lgbtqia+, le organizzazioni nate con questa mission esclusiva, come Scosse, l’esperienza di Educare alle differenze. Poi, il ruolo che hanno avuto l’arte e la cultura, portando a scuola spettacoli e audiovisivi per sensibilizzare su determinati temi. Il libro racconta come dagli anni ’60 l’educazione sessuo-affettiva esista in quasi tutta Europa e come l’Italia sia ancora fanalino di coda, facendo un excursus attraverso tutte le tappe in cui abbiamo sfiorato l’opportunità che l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole ci fosse – come nei primi anni ’90 con il dilagare dell’Aids – che si sono rivelate invece occasioni perse, perché ogni volta l’argomento non trova un dibattito parlamentale serio, viene affrontato all’indomani di un evento grave, di un suicidio di un ragazzino per bullismo omofobico o di un femminicidio di una ragazza particolarmente giovane, come nei casi di Sara Di Pietrantonio e di Giulia Cecchettin. Il libro sistematizza un racconto di dieci anni, valorizzando le realtà che hanno, in assenza di una legge, fatto l’educazione sesso-affettiva nelle scuole. E oggi diventa l’opportunità per mettere in evidenza come si stia cercando di vietare qualcosa che in realtà non è mai stato formalizzato».
Come procedono i progetti nelle scuole della Fondazione Una nessuna centomila, visto il momento di incertezza sul tema?
«Avremmo dovuto iniziare con dei progetti di formazione nelle scuole, ma ora dobbiamo aspettare gennaio perché gli istituti che, inizialmente, avevano aderito ora sono preoccupati perché la Fondazione lavora proprio sulla scuola secondaria di primo grado, che è quella sotto attacco in questo momento. C’è una grande preoccupazione da parte di genitori, docenti, dirigenti scolastici, che fanno fatica ad assumersi da soli questa responsabilità. È un clima pesante, una situazione grottesca. Rimaniamo gli unici in Europa a non avere l’educazione sessuo-affettiva nell’ordinamento scolastico e, a quei pochi progetti che si riescono a portare avanti, si mettono i bastoni fra le ruote e si vuole negare l’efficacia di questo strumento».
Qual è l’efficacia di questo strumento?
«Se si va a fare un lavoro scientifico, serio, accurato, numerose evidenze ci dicono che i Paesi che da anni hanno educazione sessuo-affettiva nelle scuole, hanno raggiunto obiettivi importanti. Penso alla riduzione del gender gap, alla diminuzione delle gravidanze precoci e delle malattie sessualmente trasmissibili – che invece oggi in Italia sono in aumento nei ragazzi e nelle ragazze – al ritardare il primo rapporto sessuale. Ormai i dati ci confermano che l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole ha prodotto effetti benefici sulle generazioni, che hanno portato nel tempo a risultati importanti. Il nostro Paese ancora rimane aggrappato a questa “teoria del gender” perché è del tutto evidente che emendamenti e provvedimenti pensati così hanno di base paure e preoccupazioni infondate e di carattere ideologico».
Nella prefazione del libro, si legge: «Affrontiamo questo tema con uno sguardo al tempo stesso individuale e collettivo, radicato nella pratica e nella teoria. Lo facciamo a partire da un punto chiave: il genere non è un’opinione, ma una categoria analitica e scientifica riconosciuta a livello internazionale. L’”ideologia gender”, al contrario, è una narrazione costruita ad arte, che ha assunto negli anni una funzione regressiva, utile a consolidare poteri, identità e assetti sociali escludenti. Smontare questa retorica significa restituire complessità al discorso pubblico e riaffermare la necessità di un’educazione fondata sulla pluralità e sul pensiero critico». È sempre meglio ribadire che il genere non è un’opinione?
«Ci sono anni di letteratura scientifica su questo. Se chiedono a noi di portare evidenze scientifiche, siamo in grado di presentare bibliografie, di conoscere esperti, di rifarci ad una dimensione ufficiale del sapere. Ma quando si nomina la teoria gender, ancora non ho chiaro a quale teoria si faccia riferimento, chi siano i portavoce, chi i rappresentanti scientifici di questa ideologia. Il punto vero è che una discussione seria, di merito, su questo tema non c’è e si continua a rimbalzare attraverso alibi da parte della politica sul “chi è che insegna queste materie?”. Non basta dire che siamo gli unici in Europa a non avere l’educazione sessuo-affettiva, bisogna anche porsi il tema di come la fanno altri Paesi che hanno iniziato tra la fine degli anni ’60 e i primi ’70, di che tipo di formazione hanno i loro insegnanti, di quali normative servono. Come Fondazione Una nessuna centomila abbiamo anche commissionato un progetto di ricerca all’Università Bicocca di Milano, presentato qualche settimana fa, che, comparando 12 esperienze europee, ci aiuta a individuare best practice, a capire qual è il percorso seguito. Proprio perché si tratta di esperienze attive da decenni, per alcuni di questi Paesi siamo ad un punto di svolta, con la variabile del web, che non esisteva fino a metà anni ’90».
Questa variabile cosa ha comportato?
«Tanta di quella violenza che si provava a prevenire con l’educazione sessuo-affettiva si è spostata sul digitale. Questo rende necessari aggiornamenti e cambi di paradigma. Oggi questi Paesi stanno cambiando le loro normative per andare incontro alla contemporaneità. Nella seconda parte della ricerca abbiamo provato a tracciare il percorso universitario, accademico, di quello che potrebbe essere il futuro insegnante di educazione sesso-affettiva nelle scuole italiane. È quasi un sogno immaginarlo. Siamo riusciti, grazie al coordinamento di Marina Calloni, docente ordinaria di Filosofia politica e sociale, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Milano-Bicocca, e siamo passati alla formulazione di un corso di alta formulazione, Educare all’affettività, che partirà a gennaio, all’Università di Milano-Bicocca, che tiene conto di tutti questi aspetti».
Nelle scuole, come Fondazione, che progetti portate avanti?
«La Fondazione ha fatto la scelta di fare progetti solo sulla preadolescenza, quindi solo sulla secondaria di primo grado. Il motivo è che abbiamo riscontrato, nell’analisi che facciamo sulla scuola italiana, un vuoto particolare nella fascia d’età 11-14 anni. Le ragioni possono essere varie: forse perché è un ciclo di studio che dura solo tre anni, perché è considerata una scuola di passaggio, forse per le enormi difficoltà legate alla fascia d’età e alla preadolescenza, un ibrido. Nello stesso tempo, però questa è proprio l’età in cui avvengono cambiamenti importanti: dal punto di vista femminile il primo ciclo mestruale, per i ragazzi le prime pulsioni sessuali, ormonali. Ed è l’età del primo dispositivo digitale autonomo. Quindi è una combinazione esplosiva, che gli stessi dati confermano come particolarmente attenzionata, perché l’abbassarsi dell’età di accesso alla pornografia online alla preadolescenza sta creando squilibri e disagi notevoli.
Abbiamo due tipi di progettualità: per noi l’optimum è stare un anno a scuola, in orario curriculare, facendo formazione agli insegnanti, laboratori in classe con i ragazzi, incontri con i genitori e poi restituzione finale del progetto. Una progettualità importante, che comporta un impegno notevole sia rispetto alla formazione che all’accoglienza all’interno della scuola».
Qual è il riscontro dei ragazzi?
«La Fondazione esiste da due anni e mezzo, portiamo questa progettualità a scuola da due anni e abbiamo un riscontro ottimo. Per due anni consecutivi siamo stati in una scuola di Napoli. Questo è un progetto che ci ha finanziato l’Uci, la scuola non finanzia, deve solo accettare il progetto, è tutto a carico della Fondazione. Il primo anno abbiamo fatto un lavoro sul linguaggio, a partire dai testi delle canzoni di Geolier, per fare un ragionamento sul controllo, sulla gelosia, il possesso. Il secondo abbiamo lavorato sull’accettazione di se stessi, con una campagna che hanno prodotto i ragazzi. Il progetto più richiesto perché comporta meno fatica per le scuole è la mattinata di sensibilizzazione. L’anno scorso l’abbiamo fatta all’interno di La fatica di essere media, progetto finanziato da Axa Assicurazioni, in venti città italiane. Partivamo da un cortometraggio su Rai Play, che si chiama 101%. L’altra questione di cui ci stiamo occupando sono gli strumenti didattici sull’educazione sessuo-affettiva perché su questa fascia d’età c’è molto poco, mentre su infanzia e scuola superiore ormai c’è una bella letteratura tra albi illustrati, serie tv, video podcast, fumetti. Sulla preadolescenza c’è un vuoto. I ragazzi partono tutti tesi all’inizio e poi si aprono e sono un fiume in piena. Per la mia esperienza, in questa fascia d’età sarebbe molto più importante lavorare con il maschile che con il femminile perché sono loro che sono più in difficoltà dentro questa dimensione».
————————————————-
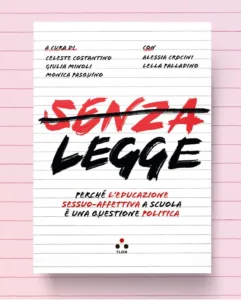 Celeste Costantino, Giulia Minoli, Monica Pasquino
Celeste Costantino, Giulia Minoli, Monica Pasquino
Senza legge
Perché l’educazione sessuo-affettiva è una questione politica
Edizioni Tlon, 2025
pp.232, € 16,00
In copertina foto Luke Porter








