
MINDSCAPES: SE GLI SPAZI ABBANDONATI DIVENTANO NUOVI PAESAGGI DELLA CURA
Dal Santa Maria della Pietà a Roma, luogo di grandi contraddizioni, conteso, ma abbandonato, uno studio sui paesaggi e i complessi manicomiali che possono tornare a vivere come luoghi di ascolto, supporto alla fragilità, cura che cura. È Mindscapes. Recinti terapeutici e welfare culturale
23 Agosto 2025
5 MINUTI di lettura
ASCOLTA L'ARTICOLO
«Santa Maria della Pietà a Roma è un luogo conteso e al tempo stesso abbandonato, con un passato ingombrante (come tutti i manicomi) ma con straordinarie possibilità, come molti altri complessi manicomiali dismessi dopo la Legge Basaglia». Punta su una riqualificazione valoriale Lucina Caravaggi, docente di Architettura del Paesaggio al Dipartimento di Architettura e Progetto presso La Sapienza Università di Roma, curatrice del volume Mindscapes. Recinti terapeutici e welfare culturale, edito da Quodlibet. Si tratta di uno studio a più mani nato qualche anno fa «quando un gruppo di ricerca del Diap Sapienza è entrato in contatto con Santa Maria della Pietà, durante l’esplorazione di “paesaggi socialmente utili” o, più esattamente, paesaggi potenzialmente utili dal punto di vista sociale», spiega la professoressa. E precisa che Santa Maria della Pietà è stato per molto tempo un sito conteso «tra coloro che non hanno mai accettato la cancellazione dell’ospedale psichiatrico – inteso a più riprese come luogo di cura delle “menti”– e coloro che, negando ogni significato positivo alla memoria dell’ex manicomio, ne reclamavano a gran voce una trasformazione radicale, immaginando al suo interno altre funzioni, da sede universitaria (come è accaduto a molti altri complessi manicomiali) a centro servizi, da albergo a sede di mercati di varia natura, ecc. Nel frattempo, il complesso manicomiale rimaneva abbandonato, teatro per lunghi anni di saccheggi e scorribande notturne, di crolli e dilavamenti».

«Straordinarie possibilità nell’interazione tra percorsi di cura e spazi abbandonati»
Lo studio ha preso il via proprio in quello spazio «segnato da profonde contrapposizioni, ma ben presto abbiamo compreso come le polemiche che andavano avanti da decenni non avessero più molto senso». Il titolo riassume in sé lo scenario di riferimento: «La fertile ambiguità del termine mindscapes (neologismo che evoca il rapporto tra psiche e paesaggio) ha alimentato la riflessione su particolari famiglie di paesaggi contemporanei, immaginati come luoghi di dialogo-riflessione-confronto sui temi della fragilità, spazi per coltivare giardini e conoscenze, dove curare curandosi, dove rifugiarsi e incontrarsi».
Infatti l’ipotesi alla base della ricerca «è che i complessi manicomiali potrebbero avere una secondo ciclo di vita di grande rilievo se posti in relazione intenzionale con i significati contemporanei di cura, prevenzione e supporto alle fragilità; nuovi spazi di transizione per nuovi paesaggi della cura». Infatti il volume contiene in vari capitolo i contributi che «hanno declinato questa riflessione da diversi punti di vista: psichiatri, architetti, paesaggisti, ecologi, hanno lavorato intorno ad alcuni concetti comuni, nel tentativo di far convivere cura, natura e nuove forme di urbanità, termini legati da una medesima prospettiva di attenzione per le fragilità contemporanee». Secondo la curatrice e gli altri autori della ricerca, esistono «straordinarie possibilità legate all’interazione tra percorsi di cura e spazi abbandonati, anche quelli dal passato ingombrante come i manicomi», riattivando in senso positivo i «recinti dell’isolamento terapeutico». Infatti «mixare socialità differenti e contemporaneamente garantire a ciascuno la possibilità di trovare il suo spazio significa garantire scambi e complementarità».
Interessante e prezioso l’excursus sul concetto di cura, introdotto «solo alla fine dell’Ottocento con la nascita della psichiatria, che trova piena caratterizzazione anche nella realizzazione del complesso del Santa Maria della Pietà di Roma, considerato un simbolo della ricerca di percorsi terapeutici coincidenti con la sperimentazione di spazi adeguati», ad esempio i giardini «all’interno dei quali trovare nicchie di silenzio e rifugi». Altra parola chiave è «custodia», termine che «non è mai stato cancellato e, nel tempo, ha ripreso forza finendo col prevalere sulla cura, soprattutto durante il fascismo, quando la custodia coinciderà con pratiche di allontanamento e separazione su vasta scala. Ne sono testimonianza materiale la recinzione esterna del complesso manicomiale, che prima era aperto alla campagna circostante, e le recinzioni intorno ai singoli padiglioni». Soltanto nel 1978, quando viene emanata la Legge 180 “Basaglia” «con cui si sancisce la chiusura dei manicomi, il termine custodia esce ufficialmente di scena. Per il Santa Maria della Pietà e per tutti gli ospedali psichiatrici italiani comincia una nuova fase di vita. La storia di Santa Maria della Pietà può essere ricondotta all’interazione tra i due termini di custodia e cura, nella loro alternanza e conflittualità».
Un’identità da non smarrire
Secondo Caravaggi, «la fase di transizione dei manicomi italiani verso nuovi cicli di vita sarà molto lunga. L’ipotesi di ricerca è che i complessi manicomiali potrebbero avere una secondo ciclo di vita di grande importanza se posti in relazione intenzionale (non casuale) con i significati contemporanei di cura, prevenzione e recupero. Si tratta di immaginare nuovi spazi di “transizione” per nuovi paesaggi della cura, cominciando a riflettere su nuove forme di interazione tra dentro e fuori, opposizione costitutiva del passato manicomiale e radicalmente messa in discussione dalla nuova psichiatria, ma ancora largamente presente nell’immaginario della salute mentale: opposizione tra città e recinti, edifici e parchi, artificiale e naturale. La vasta domanda di innovazione delle strategie terapeutiche che emerge da psicoterapeuti, operatori sociali ecc., spinge verso la sperimentazione di nuove forme di prevenzione».
In conclusione, emerge chiaramente «la volontà di non disperdere la preziosa identità di questo luogo, sottolineando il ruolo che ha avuto nella cura delle fragilità mentali. Non si può disperdere questo patrimonio, pensando che siano solo edifici – cubature da poter utilizzare come si vuole –, perché questo sarebbe un gravissimo errore». In prossimità dei padiglioni 12, 14 e 22, «dove si concentrano le attività dedicate alla cura dell’autismo, dei disturbi alimentari, alle cure palliative di malati terminali, potranno essere allestiti dei restorative garden, giardini capaci di amplificare gli effetti benefici del contatto con la natura, organizzati in piccoli spazi terrazzati da cui sia possibile vedere la campagna, sostare e riposare protetti da siepi arbustive e alberi isolati. Si tratta di spazi che possono permettere la socialità ma anche rispettare esigenze di privacy e ospitare attività che richiedano ridotti livelli di interazione». Ancora, accanto al padiglione 31, «dove sarà realizzata la biblioteca, e nella pineta retrostante il padiglione 18 (uffici municipali), è prevista la realizzazione di un training garden, un giardino attrezzato con sedute che articolano delle sale lettura e aule all’aperto, per attività di studio individuali e collettive, laboratori socio-occupazionali e allestimenti culturali e artistici. Vicino ai padiglioni 3, 7 e 9, dove verranno collocate «strutture residenziali rivolte a diversi tipi di utenti (anziani fragili, disabili) e gli ostelli, è prevista la realizzazione di community gardens, spazi disponibili per il giardinaggio».
——————————————————
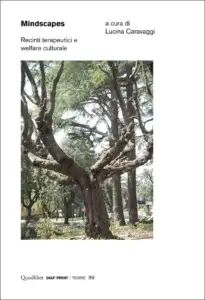 Lucina Caravaggi
Lucina Caravaggi
Mindscapes
Recinti terapeutici e welfare culturale
Quodlibet, 2025
pp. 224, € 22








