
LE VOCI SILENZIATE DELL’ACCOGLIENZA. IL DIBATTITO PUBBLICO SIA DI VOCI PLURALI
Il volume di Michele Rossi, promosso da Fondazione Migrantes, dà spazio alla relazione tra migranti e operatori sociali che genera il tessuto dell’accoglienza nel nostro paese. L’autore: «Il loro dialogare nel dibattito pubblico è possibile solo quale testimonianza, meglio se grata. Queste voci possono invece portare il contributo dell’esperienza quotidiana»
28 Aprile 2025
5 MINUTI di lettura
ASCOLTA L'ARTICOLO
L’immigrazione in Italia raccontata non attraverso numeri, leggi e demagogia politica, ma partendo dall’ascolto di chi la vive in prima persona – rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria o sussidiaria o di permesso per lavoro, senza documenti – e dagli operatori sociali che se ne occupano quotidianamente: è il senso del volume Le voci silenziate dell’accoglienza di Michele Rossi, promosso da Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana e pubblicato da Tau editrice. L’autore è coordinatore nazionale della rete Europasilo e direttore del Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale di Parma e Provincia; dottore di ricerca in Psicologia sociale presso l’Università di Parma, formatore e supervisore, collabora con Amnesty International Italia in un programma sperimentale di ricerca-azione.
«Le voci silenziate dell’accoglienza possono mostrare il sistema in una nuova prospettiva»
Il libro prova a sintetizzare il materiale raccolto durante il progetto di ricerca-azione Sinapsi (2018-2023), nato dalla sinergia tra Fondazione Migrantes ed Europasilo «con l’obiettivo di aprire spazi di discussione partecipativa sui processi di accoglienza, stimolare la produzione di contenuti riflessivi e esperienziali sul sistema di accoglienza, cogliendola “dal suo interno”. L’idea era che operatori e migranti fossero da considerarsi i principali attori dei processi che sostanziano la protezione, l’accoglienza e l’integrazione sociale. È infatti nella relazione operatori-accolti che si genera il tessuto connettivo del sistema di accoglienza; è la loro congiunzione – di qui il nome Sinapsi – a produrre significato, pratica e intelligenza collettiva, oppure a produrre cortocircuito, conflitto e esclusione», evidenzia Rossi. Eppure «la loro voce e il loro dialogare dentro il sistema di accoglienza, sul sistema di accoglienza e attraverso il sistema di accoglienza appariva e appare ancora di più oggi, fortemente trascurata se non – specie nel caso degli accolti – silenziata. La loro voce nel dibattito pubblico è spesso infatti udibile, possibile, solo limitatamente alla forma della testimonianza, meglio se grata. Queste voci possono invece intervenire nello spazio del dibattito pubblico, portare il contributo che l’esperienza quotidiana produce in termini di tentativi, soluzioni, criticità che emergono inattese, stalli, adattamenti funzionali; ma anche dei vissuti che accompagnano questa quotidianità svelando aspetti decisivi, sottili, soggettivi e mostrandoci il sistema in una nuova prospettiva».
Nel dibattito sull’accoglienza urge dire la verità
Significativa l’ampia partecipazione di persone migranti e di operatori professionali all’indagine: «Molto più che l’ampiezza numerica del campione – 350 migranti inseriti o esclusi dai sistemi di accoglienza italiani, e 298 operatori coinvolti –, la partecipazione è consistita in un coinvolgimento che ha visto, a partire dagli 8 peer researchers, ben 83 tra rifugiati e rifugiate attivarsi per fornire contatti, coinvolgere persone da loro conosciute e soprattutto farsi portatori e portartici degli scopi della ricerca, conferendo quella credibilità e quella autorevolezza necessaria per convincere tante persone a prendervi parte. Una partecipazione dunque decisamente straordinaria, anche considerando che parte della ricerca si è sviluppata negli anni della pandemia, con tutte le limitazioni e le difficoltà che questo ha comportato». Inoltre 51 intervistati, 31 rifugiati e 20 operatori, dopo l’intervista o il focus group cui hanno partecipato, hanno ricontattato spontaneamente l’autore «per aggiungere contenuti, per aggiornare sui loro percorsi, per sviluppare un concetto sul quale erano intervenuti, mostrando quanto sia urgente un dibattito che coinvolga realmente chi l’accoglienza la pratica e la vive ogni giorno».
Pressante fra gli intervistati, migranti e operatori, la richiesta di anonimato: una garanzia premessa, ma che ha «intercettato anche una paura di ripercussioni negative. Non tanto o non solo perché le dichiarazioni rese hanno talvolta assunto il carattere di una denuncia sociale (peraltro da questo punto di vista non si sono discostate da questioni ampiamente note e documentate da rapporti, inchieste, altre ricerche), quanto proprio perché, crediamo, il dibattito sull’accoglienza è ancora oggi percepito come rischioso, o quantomeno come scivoloso. Urge dire la verità in questo dibattito ma non vi è ancora la necessaria serenità per farlo con tranquillità, con anche posizionamenti critici o aperte contestazioni, ma anche, più semplicemente, proposte migliorative, idee, suggestioni. E la presa di parola di chi l’accoglienza la riceve o la fa – gli esclusi dal dibattito pubblico sull’accoglienza – è sospettosa, gravata del timore di “offendere qualcuno” con le proprie parole, di incorrere in possibili eventuali ripercussioni pratiche, di perdere rapporti ritenuti significativi».
Un racconto corale
Dalle pagine emergono «vissuti ed emozioni che per farsi comprendere hanno sfidato le barriere linguistiche ed espressive, intrecciando lingue, idiomi, farsi proverbiali, esempi concreti, immagini e metafore ardite; ma anche timidezza, riservatezze e soprattutto paure. È possibile scorgere in molti contributi la volontà che le proprie fatiche, le proprie frustrazioni, le proprie difficoltà diventino patrimonio condiviso per “migliorare”, perché altri non si trovino a vivere le medesime cose. Un approccio che testimonia sin da subito la correlazione profonda tra il vissuto personale e le dimensioni più politiche, generali, che accolti e operatori hanno messo a fuoco, partendo da loro stessi», osserva l’autore. Un «racconto corale» in cui «talvolta la voce dei migranti e quella degli operatori si completano, sfidano, discutono, si contrappongono o convergono, a distanza, ossia prima gli uni e poi gli altri, accettando una distinzione transitoria tra “noi” e “loro”».
Un percorso sempre più pieno di suoni e voci plurali
Un capitolo è dedicato alla «fiducia tra operatori e accolti, che è un tema toccato pressoché dalla totalità dei partecipanti della ricerca. Pur non essendo tra le ipotesi iniziali previste, costituisce il concetto chiave dell’intera ricerca-azione, il fulcro attorno al quale le voci silenziate dal dibattito pubblico sull’accoglienza hanno costruito il proprio sorprendente discorso, rivendicandone, con forza e determinazione, la centralità», sottolinea Rossi. «Nel corso della ricerca Sinapsi sono emersi molti temi di riflessione: dalle condizioni di vita in Italia che i migranti si trovano a vivere alle diverse forme di discriminazione percepita; dal racconto delle quotidiane odissee dei migranti all’orgoglio per i traguardi raggiunti; dalle riflessioni su come ha funzionato l’intero sistema di asilo in Italia alla comparazione tra accoglienze destrutturate e progetti di accoglienza diffusa. Questo testa rappresenta quindi una prima tappa, comunque parziale, di un più ampio percorso, che auspichiamo sempre più pieno di suoni e voci plurali, espresse un giorno, in prima persona».
—————————————–
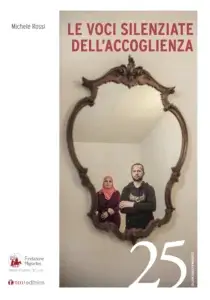 Michele Rossi
Michele Rossi
Le voci silenziate dell’accoglienza
Tau Editrice, 2025
pp.136, € 15,00








